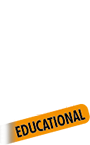CATTIVE LETTURE – “Ubik”, di Philip K. Dick
.jpg)
“Un visionario tra i ciarlatani”: oggi più che mai la definizione di Stanislaw Lem sembra cogliere le ragioni della popolarità di Philip K. Dick, di cui tanto cinema continua a subire il fascino. È ora la poetica visiva di Michel Gondry, una delle più significative, personali e riconoscibili nel panorama odierno, a confrontarsi, nell’adattamento di Ubik, con l’immaginario dickiano
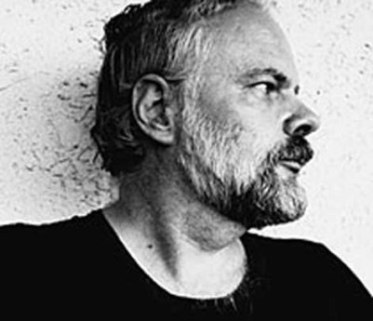 Non mancano mai occasioni per parlare ancora di Philip Kindred Dick. A quasi trent’anni dalla morte l’autore di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? e La svastica sul sole continua a essere conosciuto e amato da schiere numerose ed eterogenee di lettori (certamente molto più di quanto sia stato conosciuto e amato in vita) e il cinema continua a subire il fascino della sua opera, al punto da rendere un impiego a tempo pieno per la figlia Isolde l’attività della Electric Shepherd Productions, la società che si occupa della tutela delle opere di Dick. I guardiani del destino di George Nolfi è arrivato nelle sale italiane, per la fine del 2011 è attesa l’uscita di Radio Free Albemuth di John Simon (che racconta la crisi attraversata dallo scrittore a metà degli anni Settanta e la genesi della trilogia di Valis), e l’anno prossimo dovrebbe essere pronto il remake di Atto di forza (con Colin Farrell), mentre Michel Gondry sta lavorando alla sceneggiatura di Ubik. L’indiscutibile attualità delle opere di Philip K. Dick – o, in un certo senso, la crescente attualità – porta facilmente, e un po’ banalmente, a identificarlo come un profeta, come il più acuto messaggero dell’avverarsi dei peggiori incubi orwelliani. Ed è una tentazione più che legittima, nei riguardi di un autore che ha anticipato e rivelato la dittatura delle merci, o la possibilità per la mente umana di concepire la sparizione del mondo reale, o ancora l’evoluzione delle democrazie in sistemi iperprotettivi di se stessi, che pretenderebbero di garantirsi da ogni pericolo annullando il libero arbitrio. Il rischio, naturalmente, è di forzare il suo pensiero verso letture non sempre pertinenti, o peggio, di farne il depositario di qualche conoscenza assoluta, cosa di cui, da spirito scettico e tormentato qual era, avrebbe probabilmente sorriso: “La fantascienza è una forma d’arte ribelle, che ha bisogno di scrittori con cattive inclinazioni, come per esempio quella di chiedere sempre perché? O come mai? O chi l’ha detto?”, afferma Dick nella breve rievocazione della propria vita scritta nel 1980, a introduzione di una raccolta di racconti (Non saremo noi, Urania Mondadori, 1981); il mondo rimase sempre per lui il paradosso dell’inconoscibile, e la scrittura l’unico modo per ricercare instancabilmente, dando fondo alla propria visionarietà, l’ignoto che attende appena oltre le fragili certezze dell’apparente, del normale, del quotidiano. Ciò che è straordinario in Dick non è, o non è solo, la sua capacità di interrogare e denudare il presente proiettandovi le ombre angoscianti del futuro, ma è l’urgenza e la radicalità di quella domanda, e la preoccupazione etica, prima ancora che gnoseologica, che ne è alla base. Forse è per questo che oggi, più che mai, sentiamo di averne bisogno.
Non mancano mai occasioni per parlare ancora di Philip Kindred Dick. A quasi trent’anni dalla morte l’autore di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? e La svastica sul sole continua a essere conosciuto e amato da schiere numerose ed eterogenee di lettori (certamente molto più di quanto sia stato conosciuto e amato in vita) e il cinema continua a subire il fascino della sua opera, al punto da rendere un impiego a tempo pieno per la figlia Isolde l’attività della Electric Shepherd Productions, la società che si occupa della tutela delle opere di Dick. I guardiani del destino di George Nolfi è arrivato nelle sale italiane, per la fine del 2011 è attesa l’uscita di Radio Free Albemuth di John Simon (che racconta la crisi attraversata dallo scrittore a metà degli anni Settanta e la genesi della trilogia di Valis), e l’anno prossimo dovrebbe essere pronto il remake di Atto di forza (con Colin Farrell), mentre Michel Gondry sta lavorando alla sceneggiatura di Ubik. L’indiscutibile attualità delle opere di Philip K. Dick – o, in un certo senso, la crescente attualità – porta facilmente, e un po’ banalmente, a identificarlo come un profeta, come il più acuto messaggero dell’avverarsi dei peggiori incubi orwelliani. Ed è una tentazione più che legittima, nei riguardi di un autore che ha anticipato e rivelato la dittatura delle merci, o la possibilità per la mente umana di concepire la sparizione del mondo reale, o ancora l’evoluzione delle democrazie in sistemi iperprotettivi di se stessi, che pretenderebbero di garantirsi da ogni pericolo annullando il libero arbitrio. Il rischio, naturalmente, è di forzare il suo pensiero verso letture non sempre pertinenti, o peggio, di farne il depositario di qualche conoscenza assoluta, cosa di cui, da spirito scettico e tormentato qual era, avrebbe probabilmente sorriso: “La fantascienza è una forma d’arte ribelle, che ha bisogno di scrittori con cattive inclinazioni, come per esempio quella di chiedere sempre perché? O come mai? O chi l’ha detto?”, afferma Dick nella breve rievocazione della propria vita scritta nel 1980, a introduzione di una raccolta di racconti (Non saremo noi, Urania Mondadori, 1981); il mondo rimase sempre per lui il paradosso dell’inconoscibile, e la scrittura l’unico modo per ricercare instancabilmente, dando fondo alla propria visionarietà, l’ignoto che attende appena oltre le fragili certezze dell’apparente, del normale, del quotidiano. Ciò che è straordinario in Dick non è, o non è solo, la sua capacità di interrogare e denudare il presente proiettandovi le ombre angoscianti del futuro, ma è l’urgenza e la radicalità di quella domanda, e la preoccupazione etica, prima ancora che gnoseologica, che ne è alla base. Forse è per questo che oggi, più che mai, sentiamo di averne bisogno. La porta rifiutò di aprirsi. Disse invece: “Cinque centesimi, prego”.
La porta rifiutò di aprirsi. Disse invece: “Cinque centesimi, prego”.Come fa Glen Ruciter, direttore di un’agenzia antitelepati, a comunicare con la moglie Ella, intrappolata in un aldilà di semi-vita? Perché Joe Chip scompare dal suo mondo del 1992 per ritrovarsi nell’America degli anni Trenta? Com’è possibile che riceva oscuri messaggi sui muri e sugli specchi dei bagni dal suo capo, quando questi è rimasto ucciso da una bomba esplosa sulla Luna? E cos’è in realtà Ubik, il prezioso spray che ritarda i processi degenerativi? Si può, grazie a esso, condurre un’esistenza apparente, senza rendersi conto che si è morti?
Siamo tutti fantasmi. La merce non ci domina, ci è sopravvissuta, ci ha annullato da un pezzo. È la gratificazione dei sensi, il sostituto del sesso, è ubiqua come la manifestazione del divino. Ubik (1966) è il romanzo più pessimista di Philip K. Dick; una metafora potentissima del legame malato tra gli uomini e gli oggetti – della reificazione umana nella sua forma più estrema – e insieme la messa in discussione dell’adeguatezza del nostro sistema di pensiero meccanicistico e lineare a decifrare la realtà che ci circonda. Joe Chip vive in una casa dove tutto è a pagamento e precipita in una regressione temporale che ha nella mutazione degli oggetti – una cucina a gas cambia in una a carbone, un’auto moderna diventa una Ford del 1929 – la sua rivelazione primaria. I personaggi di Ubik dispongono di una propria teoria della realtà che nel corso della trama viene falsificata, sostituita da una nuova teoria in grado di spiegare l’avvenimento falsificante, ma che è a sua volta insidiata da una diversa consapevolezza che non conduce a un’unica spiegazione ma a una pluralità di soluzioni possibili. Essi sperano sempre, fino all’ultimo, che la loro percezione della realtà sia quella vera. Ecco allora che Ubik, lo spray miracoloso, l’estrema apparenza vendibile, offre loro la verità d’emergenza, perché parla l’unico linguaggio comprensibile nella (non)esistenza di persone il cui apparato percettivo/cognitivo è incapace di liberarsi dalla presenza degli oggetti. Ubik si rivela nel prologo del capitolo finale come il principio creatore dell’Universo, il Logos, il Verbo, parodisticamente incarnato nel logo di un banale prodotto commerciale. Dietro le sembianze dell’Immateriale, si cela l’insidia della vita inorganica; e la sostanza divina non dona la beatitudine della grazia, ma concorre a nascondere una realtà di morte.
 Una sceneggiatura di Ubik la scrisse lo stesso Dick nel 1975 (Fanucci l’ha pubblicata nel 1998), quando il regista francese Jean-Pierre Gorin lo raggiunse a Los Angeles per proporgli la realizzazione di un film ispirato al suo romanzo, ma il progetto per ragioni finanziarie non andò in porto, e il primo film tratto da un’opera di Dick, come sappiamo, sarà Blade Runner. Dopo anni di trasposizioni più o meno dirette, di un’infinità di contaminazioni, echi e fascinazioni dickiane, è ora la poetica visiva di Michel Gondry, una delle più significative, personali e riconoscibili nel panorama odierno, a confrontarsi con gli incubi e le ossessioni del grande autore americano.
Una sceneggiatura di Ubik la scrisse lo stesso Dick nel 1975 (Fanucci l’ha pubblicata nel 1998), quando il regista francese Jean-Pierre Gorin lo raggiunse a Los Angeles per proporgli la realizzazione di un film ispirato al suo romanzo, ma il progetto per ragioni finanziarie non andò in porto, e il primo film tratto da un’opera di Dick, come sappiamo, sarà Blade Runner. Dopo anni di trasposizioni più o meno dirette, di un’infinità di contaminazioni, echi e fascinazioni dickiane, è ora la poetica visiva di Michel Gondry, una delle più significative, personali e riconoscibili nel panorama odierno, a confrontarsi con gli incubi e le ossessioni del grande autore americano.Per il lettore, Ubik è un’esperienza che smantella le usuali coordinate interpretative, un testo che scivola fuori da se stesso, diventa metatesto, scorre in direzioni inaspettate dove un evento può risultare incomprensibile all’interno di un dato universo di riferimento ma può trovare senso in un altro; una lettura straniante che invita a non chiedersi quale sia la spiegazione giusta e lascia addosso la sensazione che il nostro abituale sistema cognitivo sia stato sbeffeggiato alla grande. L’idea di cinema di Gondry, che costantemente va ad investire il ruolo dello spettatore per scombussolarne e risvegliarne l’immaginazione, appare in questo senso straordinariamente in sintonia tanto con la scrittura che, in larga misura, con l’immaginario dickiano. Certo l’universo del regista de L’arte del sogno e Be Kind Rewind ha i colori, i suoni, le visioni di una meravigliosa follia onirica; quello di Dick, di un’apocalisse permanente. Ma la circolarità, la struttura a incastri, la stratificazione dei piani rappresentativi e il loro sconfinamento gli uni negli altri, la rielaborazione creativa del procedere non lineare della mente umana, ogni costante insomma dell’opera di Gondry sembra in grado di restituire l’essenza del romanzo e, più in generale, dell’intera produzione dickiana. Che è quella di spargere il dubbio, evocare i “mondi possibili”, confrontarsi con l’ipotesi che il reale come il divino possano essere proiezioni mentali: Now we see through a glass, darkly.
Più forte del suo nichilismo, quello che lo porta a sostenere, ne La svastica sul sole: “Qualsiasi cosa accada, è male al di là di ogni possibilità di paragone. Perché lottare, allora? Perché scegliere? Se tutte le alternative sono uguali… ”, è in Dick questo istinto, profondamente umano, a tentare comunque di spingersi oltre la visione confusa per speculum et in aenigmate, frenando il contagio dell’apparenza e del simulacro. Con l’acutezza dello sguardo che posava sul mondo, e che con eguale lucidità sapeva rivolgere verso se stesso.
Array