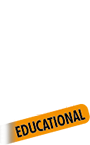Parthenope, di Paolo Sorrentino
Dietro gli eccessi di stile, i dialoghi a effetto, la deformazione grottesca, il cinema del regista trova spesso delle improvvise vertigini e ha uno stupore spielberghiano. CANNES77. Concorso

Il sole, il mare, le lacrime. È una creatura mitologica Parthenope. Nasce in mare nel 1950, e da lì riemerge nel 1968. Lo stesso mare che è il continuo sfondo nella sua vita, lo stesso che la accompagna nei suoi desideri o assiste impotente a un atroce dolore familiare che ha segnato per sempre la sua vita. Parthenope ha il volto di Celeste Della Porta. Attraverso di lei Sorrentino ha gli occhi e le ‘mani sulla città’, su Napoli che stavolta prende le forme di una divinità. L’atto d’amore di Sorrentino verso la città, a differenza di quelli di Martone e Capuano che si lasciano assorbire in un cinema personalissimo dal suo respiro, è un viaggio nel tempo assieme alla sua protagonista. Napoli e Parthenope sono la stessa cosa. Si ama, si detesta (come l’impietosa accusa nello spettacolo dell’attrice Greta Cool, interpretata da Luisa Ranieri), si riabbraccia ancora, si abbandona di nuovo e infine richiama per l’ennesima volta. Dal 1950 al 2023. Dalla carrozza, legame con la fastosa grandezza incarnata da Achille Lauro, al carro-barca in occasione dello scudetto del Napoli dello scorso anno.
Ha uno stupore spielberghiano il nuovo film di Paolo Sorrentino. Dietro gli eccessi di stile, i dialoghi a effetto, la deformazione grottesca di un cinema incontrollato anche nella sua durata che però non si vuole fermare e che, come Fellini, preferisce sempre un’inquadratura in più, Parthenope riscopre Napoli e la guarda come se fosse la prima volta. Così come faceva Fellini con Roma. E come lui, entra in una dimensione onirica in tutta la sequenza estenuante ma anche abbagliante con Tesorone che ha il corpo e l’anima di Peppe Lanzetta. La meraviglia è quella di Parthenope che reagisce davanti a qualcosa di nuovo con la stessa innocenza e meraviglia di Elliot e i suoi amici davanti a E.T., che rincorre l’amore assoluto anche se, forse è consapevole che non può raggiungerlo mai. Lo cerca non solo nel piacere fisico, ma nella poesia, nella sete di conoscenza, di sapere. Tutto il suo rapporto con il professore universitario Marotta, interpretato da Silvio Orlando, in puro mood Sorrentino, è tra le cose più travolgenti del suo cinema perché è un terremoto dialettico di un rapporto che è qualcosa di indefinibile. Maestro? Padre? Amico? Fratello più grande? Amore impossibile? Il momento in cui l’uomo, dopo molti anni, le apre le porte della sua stanza per mostrarle il figlio gigantesco fatto di acqua e sale, è un’altra apparizione da Spielberg. Lo stupore, l’estasi.
Parthenope e il fratello Raimondo sono i figli ideali di Toni Servillo nella famiglia di Sorrentino. Ballano cercando di fermare il tempo, proprio come Titta Di Girolamo in Le conseguenze dell’amore e Jep Gambardella in La grande bellezza. Non c’è l’attesa del primo nell’albergo di Lugano né la voglia che non succeda nulla e tutto resti immobile in una Roma tra mondanità e squallore del secondo. Parthenope e Raimondo cercano di fermare la loro giovinezza, si muovono con la sigaretta in bocca e la cenere che cade proprio come Servillo. O trovano l’assoluto o si perdono per sempre. Non c’è via di mezzo.
“Siamo stati bellissimi. E in mezzo così infelici”. Un dialogo che potrebbe idealmente arrivare da una versione uncut di C’eravamo tanto amati. Parthenope è sempre in bilico tra grandezza e miseria, sfacciataggine e seduzione. Riprende la tentazione di filosofeggiare un po’ troppo rispetto al travolgente e bellissimo È stata la mano di Dio. Ma entrambi i titoli si prendono per mano nel modo in cui prende forma il baratro della morte, la caduta e la rinascita, la vita come un infinita colonna sonora. Eh si, Napoli è anche qui “mille culure” e “mille paure”. Ride e piange assieme alla sua protagonista. Il cinema di Sorrentino, andando avanti con gli anni, non si vergogna più delle sue lacrime. Prova a nasconderle nei suoi ralenti (gli scontri degli studenti contro la polizia) ma poi seduta lì c’è Parthenope da sola, seduta sui gradini, con una tristezza infinita che non riesce a fermare.
Ci sono sempre dei personaggi che sembrano arrivare dall’oltretomba, dall’agente Lidia Rocca allo scrittore John Cheever portato sullo schermo da Gary Oldman. Ma stavolta non invadono la storia, la attraversano soltanto e, quando lasciano il segno del loro passaggio, possono diventare momenti di altissima intensità come il poeta che dice alla ragazza: “Non voglio rubare un istante della tua giovinezza”. Sorrentino, al decimo film per il cinema, ci fa vedere sullo schermo come sono fatte quelle parole che diventano improvviso slancio, tentazione e abbandono, vita e morte, ironia e malinconia. Incrocia improvvisamente una comicità degna dei Monty Python – la scultura di Drago Azzurro come omaggio a Greta Cool – e cita Billy Wilder, accenna al fantasy apolcalittico (l’arrivo a Napoli del colera) e nella devastazione nei vicoli trova momenti di improvvisa magia come nella scena con i catini illuminati. È troppo? Probabilmente sì, come il finale con Stefania Sandrelli che si poteva tagliare, anzi no, perché l’ultima inquadratura è tra quelle più fondamentali di tutto il film e senza quelle che ci stanno prima crolla tutto. Ma è troppa anche l’intensità di un cinema che per gran parte è diventato vertiginoso e trova il suo Jules e Jim in quel ballo a tre sulle note di Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante che è tra le scene del cinema italiano che ci ricorderemo per sempre, anzi forse ci portiamo nella tomba.

Lo stile è sempre ingombrante in Sorrentino? E allora? Stavolta chissenefrega. Perché, come nel film precedente, nella forma stavolta trova il cuore. Con gli occhi di Parthenope che sono spenti e poi si accendono all’improvviso. “Che cos’è l’antropologia?” chiede spesso la ragazza al professor Marotta. Nella sua risposta – che scoprirete quando vedrete il film – c’è tutto il cinema di Sorrentino. Nel male ma, in questo caso e nella sua produzione più recente, nel bene. Per questo Parthenope continua ad ossessionarci e non ci vuole lasciare. Un inno alla bellezza e all’eternità. Forse ‘era già tutto previsto’. Forse no.